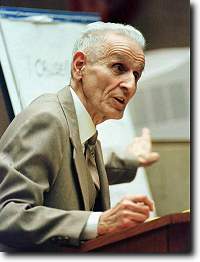Non riuscì mai a spezzare il legame con Drusilla «la Mosca» per raggiungere Irma Brandeis a New York
di Silvio Ramat
Leggendo Montale per me o tentando di «spiegarlo» ad altri, avevo sempre pensato e proclamato le manchevolezze dei suoi umani amori: come se ogni volta la loro funzione fosse legata a un esito di poesia e perciò il valore di un sentimento si misurasse da quello dei versi che aveva saputo ispirare. Ma oggi, di fronte alle Lettere a Clizia, curate da Rosanna Bettarini (autrice anche dello splendido saggio introduttivo), Gloria Manghetti e Franco Zabagli (Mondadori, pagg. XLV-376, euro 25), non potrei confermarmi in quell’opinione, anzi la giudico superficiale e presuntuosa, visto il carico di ansioso dolore che grava su questo percorso a ostacoli, lungo il quale a un dato momento si registra la sconfitta: se non d’una passione, del disegno che l’ha tenuta in vita per anni.
Quale disegno, quali anni? Nell’estate del 1933 Montale, a Firenze, dirige il Gabinetto Vieusseux (goliardicamente ribattezzato «WC» nell’epistolario), e qui gli fa visita una graziosa borsista americana, Irma Brandeis, ammiratrice degli Ossi di seppia. Per entrambi è il colpo di fulmine, e poche settimane passate insieme bastano a far sì che, quando lei si reimbarca per gli Stati Uniti, all’inizio di settembre, il progetto di ricongiungersi appena possibile e for ever, di là o di qua dall’Oceano, sembra concreto. È l’argomento che pervade e giustifica, da allora e per oltre un quinquennio, lo scambio epistolare fra il poeta e colei che più tardi, ormai irrecuperabilmente remota, riceverà da Montale il mitologico, solare nome di Clizia. È doveroso che la raccolta di queste 155 lettere (del 1933-39, integrate da un postremo biglietto del giugno 1981: Montale morì poi in settembre) s’intitoli, appunto, A Clizia, giacché la sua persona si fa sùbito, virtualmente e di fatto - cioè nei versi -, anche personaggio. Sono per lei o meglio le appartengono quasi l’intero corpo dei Mottetti, nucleo del futuro (1939) libro de Le occasioni, e altre liriche: a cominciare da Costa San Giorgio (1933) non facile da sceverare nei suoi oggetti simbolici ma, secondo Montale - che, attingendo al proprio individuale patrimonio di poeta, nei primi tempi si firma «Arsenio» -, talmente connessa all’ardente avvio della loro storia da non poter risultare enigmatica all’intelligenza di Irma.
Come è quasi regola per i carteggi che lo coinvolgono, ci mancano le lettere a Montale. È fama ch’egli usasse distruggerle, o le smarrisse: di tutto incolpando traslochi, alluvioni e accidenti varî. Così, di Irma-Clizia ci rimane, acclusa all’odierno volume, un’unica lettera - del 21 febbraio 1935 - perché mai spedita: documento della sempre più drammatica temperatura di una relazione svoltasi quasi interamente per iscritto, dato che furono appena tre, e brevi, i soggiorni italiani di lei: nelle estati del 1933, del ’34 e del ’38.
Fin dal 1983 la Brandeis (1905-1990) aveva affidato ad Alessandro Bonsanti, per decenni direttore del Vieusseux, queste lettere: da conservare nell’Archivio fiorentino che oggi a Bonsanti s’intitola, col patto che venissero dissigillate e rese pubbliche dopo almeno venti anni. E adesso, a carte scoperte, il capitolo montaliano che ci si dischiude è complicato solo se badiamo alla proliferante aneddotica di cui, per divertire l’amata, Montale è prodigo, magari aiutandosi con qualche disegnino spiritoso. Sono episodî e raccontini (Irma, che ne scrive di suoi per il New Yorker, potrebbe all’occorrenza trarne spunto), con personaggi buffi e improbabili, in anticipo sul gusto che nel dopoguerra caratterizzerà le prose della Farfalla di Dinard; eventi per lo più banali a specchio della cerchia, letteraria e non, di una Firenze che Montale vive e rappresenta in un periodo di fascismo consolidato quanto grottesco e fatuo nelle sue manifestazioni.
Complicato, sì dunque, ma solo per la varietà delle comparse, l’organico delle lettere a Clizia; semplice, invece, e addirittura elementare nella sostanza, che si riduce a un dilemma: trovare o no il coraggio, per questo amore nuovo e meraviglioso, di dire addio all’altra donna, più anziana di lui, che da anni ha accolto il poeta nella propria casa. Del ruolo e della stessa esistenza di lei (Drusilla Tanzi, ossia «la Mosca», evocata post mortem negli Xenia, ma qui nel carteggio designata con una reticente, intimorita X) Montale tace con Irma fino all’estate del 1934. Dopo, non c’è più facoltà di allentare la stretta di quel nodo, e si capisce, poiché il gioco si svolge sopra un terreno infido, reso più infido dalle scenate ricattatorie: la Mosca minaccia di suicidarsi se lui andrà a vivere con Irma. Questo lo terrorizza e gl’impedisce di veder chiaro nel proprio domani, che in auspicio comporta un impiego a New York: idea accarezzata a più riprese ma con un fervore piuttosto pigro, inadeguato alla bisogna. Lui promette, fissa e di continuo rimanda le scadenze; cerca di farsi, se non compatire, giustificare da Irma per la lentezza - in verità è una stasi fatale - del processo liberatorio. Del vincolo che lo angustia dà anche un’interpretazione freudiana, dichiarandosi (marzo 1936) prigioniero di un complesso di Edipo che lo rende «vile e contraddittorio»; e nell’ottobre del ’38, ribadito che è sicuro di spezzare il laccio, sostiene di non odiare X, bensì di averla collocata al posto della propria madre. Ora, siccome le madri spesso divorano i figli, lui non vuol farsi ingoiare da lei!
Pressappoco una metà di queste lettere sono vergate in inglese. Un inglese «pessimo», che Montale tuttavia adopra perché «traduce meglio» i suoi «sentimenti», laddove - confessa - «quando ti scrivo in italiano mi trovo improvvisamente speechless. Mi pare di essere un altro e che tu pure sia un’altra». Quali sentimenti? Nessun vocabolo ha in queste lettere una frequenza pari a quella di «orrore» (e dei connessi «orribile», «orrendo»...), indice di un peggioramento irreversibile della condizione di Montale. Domandarsi se egli sapesse o no, in cuor suo e fin da principio, che la storia si sarebbe conclusa così malamente non ha gran senso; il lettore comincia a intuirlo abbastanza presto, ma solo verso l’epilogo - durante il 1938 - nelle reiterate dilazioni dell’ora zero dell’affrancamento avverte un segno più remissivo, come di chi, avendo calcolato il rapporto di forze tra sé e l’avversario, più non dubiti della propria inferiorità.
E malgrado vada in porto la non agevole pratica di staccarsi dal Vieusseux - si perde lo stipendio ma anche si rimuove uno dei due ingombri al volo felice tra le braccia di Clizia -, stanchezza e fatica man mano prevalgono, e quell’«orrore» che Montale sente in sé e di sé, della (e nella) propria esistenza è fomite a una disperazione che nessuna conferma alleggerisce, non, per esempio, questa (26 novembre 1938): «... tutto procede normalmente e ogni giorno che passa è un giorno di meno del tempo negativo della nostra separazione». All’altro capo del filo, anche se non ne possediamo i documenti espliciti, Clizia avrà capito da un pezzo l’antifona. Diminuisce, a questo punto, la voglia di descrivere le imprese dei fiorentini, stanziali o di passaggio, e poco spazio si riserva ai taglienti pareri su protagonisti e comprimarî di un mondo che gli occhi di Clizia avevano afferrato di scorcio.
Nel carteggio scorrono le trattorie, gli osti, le botteghe capaci di suscitare il ricordo... In anni di generalizzato ossequio al Duce («il Cardinale» nel cifrario del carteggio), v’è chi approva e s’adegua, come Ungaretti, e chi si sceglie una strada più defilata. In proposito, la tipologia è vasta, e d’altronde a Clizia piace che le si parli di Loria «monster of Lochness», o di Saba «con la sua testa pelata e la sua ossessione psicoanalitica»; di Moravia (bravo ma supponente e negato a intender la poesia), o di curiose coppie come i Praz e i Piovene; di Vittorini, di Bonsanti, dei simpatici Gadda e Palazzeschi... Irrompono fra gli altri due giovani fenomeni: il filologo poliglotta Contini e l’onnivoro Bazlen, mentre nell’area parentale spicca la figura della sorella Marianna, uccisa dal cancro nel 1938.
La lirica montaliana avrebbe dischiuso parecchi dei suoi segreti solo sul tardi, specie negli Altri versi, stampati davvero in extremis. Lì, accanto a Clizia, riemergono dalla memoria le amiche di lei e quella Pensione Annalena, in via Romana a Firenze, che le ospitò nel fatidico luglio del 1933. Avessimo anche le sue lettere, vorremmo ripercorrere questa relazione d’amore dalla parte di lei, di Clizia, sulla cui vita e opera di scrittrice e studiosa esistono pur testimonianze e ricerche molteplici. Tra di esse, due recenti monografie di Paolo De Caro, Journey to Irma e Irma politica, riferimenti obbligati nelle più che ottanta pagine di note che corredano il volume. Del modo in cui Montale seppe e riuscì ad amarla, queste lettere dicono sinceramente lo slancio e i limiti. «Ti scriverò sempre, se permetti. E ti abbraccio, ma con un orrore e una vergogna infinite. Non posso scrivere a mano perché le mani ballano il fandango», è il congedo che il «tutto tuo E.» pone alla penultima lettera (23 giugno ’39); poi nell'ultima, dell’11 dicembre ’39: «Io ti voglio più bene dei miei occhi e non so perché insisto a restar vivo: forse perché l’ho promesso a te? Tutto è troppo orribile». Più d’una di queste parole, cupe e sfiduciate, si trasferirà nelle liriche degli anni che s’approssimano, quelli 1940-43 di Finisterre: ma chi attraverso le lettere di Montale a Clizia segua il percorso di una passione autentica e sfortunata, non avrà certo come suo primo impulso quello di verificare la portata degli eventuali travasi dal registro epistolare al registro della poesia.
«Il Giornale» del 12 luglio 2006